Quando viaggiare non è un’opzione praticabile per i motivi che tutti sappiamo ed è giusto fermarsi e stare in casa finché l’onda non sarà passata. E dalla poltrona del salotto, dalla sedia in balcone, dal comodo del proprio divano si può comunque continuare a muoversi con la mente mettendo in pratica quello che i britannici chiamano “armchair travel”, ovvero la lettura di libri di viaggio. Reportage che permettono una innocente evasione in compagnia di chi è partito per saziare la sua curiosità o lo spirito d’avventura ed è tornato per raccontarlo. Racconti di prima mano di mondi lontani e diversi, esperienze ricche di passione, empatia e divertimento spesso in zone periferiche che magari mai visiterete, ma che stuzzicano fantasia e voglia di scoprire. E poi, chi lo sa, non è detto che a emergenza finita, non si decida di partire con un libro sotto braccio per visitare i luoghi di cui si è letto in questi giorni…
Ecco la ventiquattresima tappa.
__________________________
«Dall’11 al 18 marzo 1995 io, volontariamente e dietro compenso, mi sono sottoposto alla crociera “7 notti ai Caraibi” a bordo della motonave Zenith, una nave da 47.255 tonnellate di proprietà delle Celebrity crociere, una delle volte venti compagnie di crociera che attualmente operano fra la Florida e i Caraibi». Era una crociera extralusso, a bordo circa 500 americani e il doppio di equipaggio. «Cittadini americani maggiorenni e benestanti che chiedono all’ufficio relazioni con gli ospiti se per fare snorkeling c’è bisogno di bagnarsi, se l’equipaggio dorme e a bordo e a che ora è previsto il Buffet di mezzanotte». Tra questi cittadini americani c’era anche David Foster Wallace, uno che di domande ne fa poche ma ascolta tanto, osserva altrettanto, e poi – nonostante l’ansia – scrive. «Devo dire che ho vissuto il reportage commissionatomi con una sorta di fobia della prestazione».
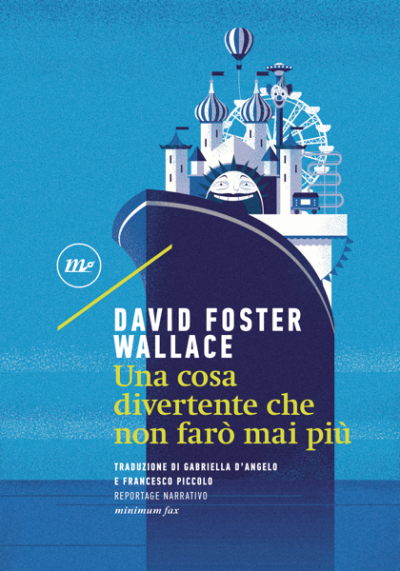
Il reportage era destinato alla rivista americana
Harper’s e nella sua versione “libro” è una delle migliori letture possibili sull’industria delle crociere in salsa americana. Perché in definitiva
Una cosa divertente che non farò mai più –
edito in Italia da Minimum Fax che nel 1998 ha avuto il merito di pubblicarlo quando pochi avevano sentito nominare DFW al punto che è stata la prima traduzione all’estero di una sua opera – è un gran libro, c’è poco da aggiungere.
O ce ne sarebbe tantissimo, ma toglierebbe il piacere semplice e diretto della lettura. Perché come tutti i libri di David Foster Wallace anche questo è tante cose insieme: una satira spietata sull’opulenza e l’industria divertimento di massa, un’analisi altrettanto spietata della società americana di oggi, una pagina di humor ben riuscita, un saggio dei viaggi possibili all’interno dell’universo emotivo dell’autore. E soprattutto un assaggio – per chi non lo conoscesse – di come a un certo punto sulla scena letteraria americana è mondiale sia arrivato un uomo bianco americano – David Foster Wallace – che ha cambiato i canoni dello scrivere.
Un uomo che imbarcato su quella motonave ha «visto spiagge di zucchero e un’acqua blu limpidissima (...) e ha sentito il profumo dell’olio abbronzante quando è spalmato su oltre dieci tonnellate di carne umana bollente». Ma anche visto «tramonti che sembravano disegnati al computer e una luna tropicale che assomigliava più a una specie di limone dalle dimensioni gigantesche sospeso in aria che alla cara vecchia luna di pietra degli Stati Uniti d’America che ero abituato a vedere».
Ma che ha anche «partecipato (molto brevemente) a un trenino a ritmo di conga» e chissà quanto vergognandosi. Un uomo che ha scritto un libro talmente ben riuscito che quasi paradossalmente ti fa venire voglia di prenotare subito una settimana a bordo di una qualunque nave crociera, per capire se davvero è una cosa divertente che poi non farete più.
Scopri i luoghi delle altre Parole in viaggio

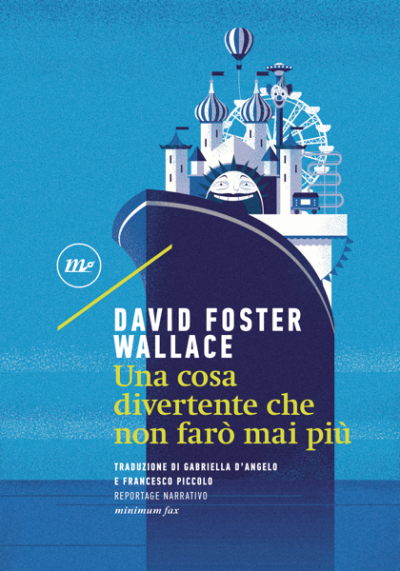 Il reportage era destinato alla rivista americana Harper’s e nella sua versione “libro” è una delle migliori letture possibili sull’industria delle crociere in salsa americana. Perché in definitiva Una cosa divertente che non farò mai più – edito in Italia da Minimum Fax che nel 1998 ha avuto il merito di pubblicarlo quando pochi avevano sentito nominare DFW al punto che è stata la prima traduzione all’estero di una sua opera – è un gran libro, c’è poco da aggiungere.
Il reportage era destinato alla rivista americana Harper’s e nella sua versione “libro” è una delle migliori letture possibili sull’industria delle crociere in salsa americana. Perché in definitiva Una cosa divertente che non farò mai più – edito in Italia da Minimum Fax che nel 1998 ha avuto il merito di pubblicarlo quando pochi avevano sentito nominare DFW al punto che è stata la prima traduzione all’estero di una sua opera – è un gran libro, c’è poco da aggiungere. 

