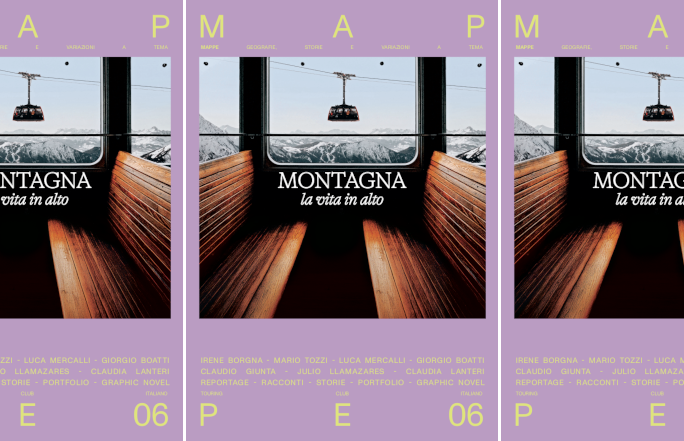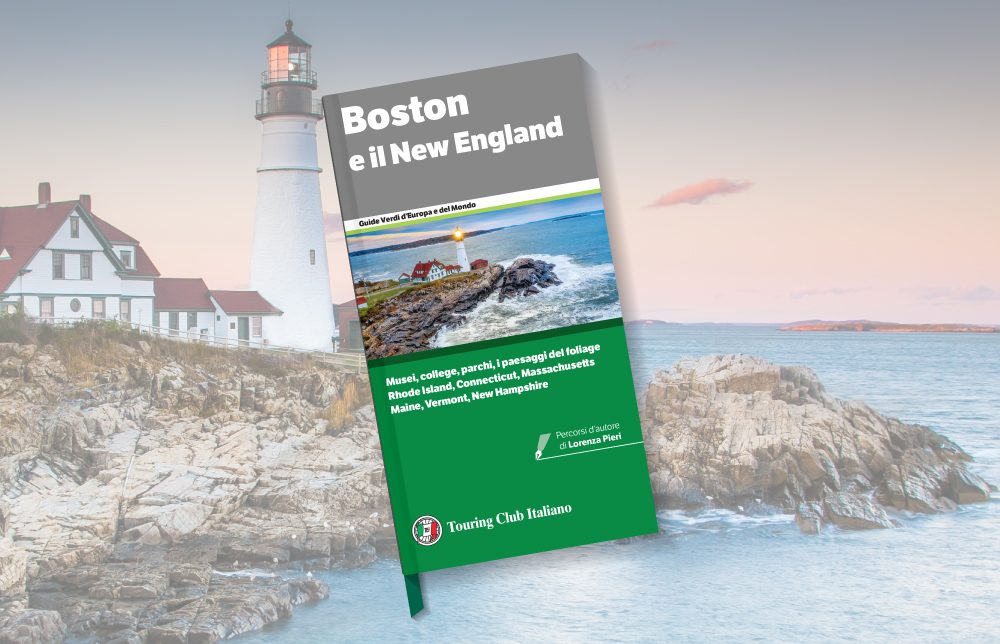
Questo racconto è contenuto nel nuovo numero di MAPPE, che esplora la vita in alto, la montagna come ultimo spazio di lentezza volontaria, condizione di precarietà deliberata, esercizio di sottrazione.
Ho incontrato le mie prime nevi nella periferia torinese, dove sono nato, nel 1966.
Dei 30 centimetri caduti tra il 16 e 17 febbraio 1967 è difficile che mi ricordi, non avevo nemmeno un anno, ma forse dei 41 di fine dicembre 1970 è possibile che nella memoria qualcosa sia rimasto: il paesaggio urbano magicamente trasformato, la gioiosa atmosfera del periodo natalizio. Con le grandi nevicate padane di metà gennaio 1985 (42 cm su Torino), fine gennaio 1986 (56 cm) e metà febbraio 1987 (63 cm), la mia strada era ormai decisa: avrei studiato meteorologia, climatologia, glaciologia, cominciando proprio dai dati della capitale subalpina che ho scoperto in polverosi archivi risalire addirittura alla fine del Settecento.
Grazie ai primi computer domestici ecco emergere dall’oblio i risultati della serie nivometrica fose più lunga al mondo, che dipinge una città nordica, con molti inverni antichi nei quali si accumulava più di un metro e mezzo di neve. Poi, dopo gli ultimi “bianchi inverni” 1985-87, ecco farsi avanti un’inedita e persistente diminuzione, associata all’aumento della temperatura. Oggi a Torino cadono poco più di 5 centimetri all’anno, circa il 10% rispetto alla media del periodo 1787-1989. Si è chiusa un’epoca.
Da Torino alle Alpi il passo è breve. Le gite di famiglia mi portavano nel Gran Paradiso, sulle piste da sci della val di Susa e nelle valli di Lanzo. Qui mi capitò di scoprire la diga più elevata d’Europa, il lago della Rossa, a quota 2720 metri, dove dal 1938 si misura giorno per giorno la neve. Trovare quei registri manoscritti dai guardiani della diga, con numeri per me da capogiro, fu un’emozione che diventerà nel 1992 una delle mie prime pubblicazioni scientifiche: in media cadono lassù otto metri di neve all’anno, nell’inverno 1971-72 se ne registrarono ben 15, con un massimo spessore al suolo di 5,5!
La spinta a comprendere il mondo della neve mi porterà così ai 3000 metri del ghiacciaio Ciardoney, nel Gran Paradiso, che diverrà un vero e proprio laboratorio internazionale, oggi inserito nel World Glacier Monitoring Service. Nel 1986 lo raggiunsi per la prima volta a piedi dalla valle Soana, dopo una salita di 2000 metri di dislivello. Da allora, ogni tarda primavera, è in elicottero che andiamo a misurare l’accumulo di neve invernale, con scavi e trincee che talora giungono a più di 6 metri di profondità.

Oltre al microscopio e al computer, pure la pala è un buono strumento per conoscere la neve: la fendi, la rompi a colpi se è gelata, la pesi, la sposti, ti fa sudare, ti fa bruciare occhi e pelle di luce solare riflessa. Per 364 giorni all’anno con i colleghi facevamo solo congetture su quanta neve avremmo trovato nella nostra visita sul posto, poi l’informatica ha reso disponibili strumenti impensabili e dal 2012 una stazione meteorologica automatica con webcam trasmette via radio tutti i giorni dati e immagini del ghiacciaio. Ora mi sveglio al mattino e mentre sorseggio il caffè al calduccio vedo cosa hanno combinato le tempeste nella notte, quanto è alta la neve e dove tira il vento. Mentre scrivo, è il 12 maggio 2025, ci sono 260 centimetri di neve.
Solo alla fine dell’estate sapremo se il caldo se la divorerà tutta, come avviene sempre più di frequente, o se una parte si conserverà per nutrire il ghiacciaio, da anni sempre più magro e in agonia, come ovunque nel mondo. Ormai, in questo primo quarto di secolo sulle Alpi perdiamo ogni anno circa un metro e mezzo di spessore di ghiaccio e nelle stagioni più calde e asciutte – come l’estate 2022 – si arrivano a consumare anche quattro metri di ghiaccio: la sorte dei modesti ghiacciai alpini è ormai l’estinzione entro il 2100.
Con tutti i dati raccolti in decenni di febbrile attività, sotto il coordinamento del centro di ricerca Eurac di Bolzano abbiamo pubblicato un vasto lavoro collettivo sull’innevamento dell’intero arco alpino, Observed snow depth trends in the European Alps: 1971 to 2019. Non ci sono dubbi, nevica di meno: circa l’85% delle località alpine italiane ed estere mostra riduzioni dell’innevamento più evidenti in primavera, sotto i 2000 metri e al sud delle Alpi, dove la lunghezza della stagione innevata in cinquant’anni è diminuita di 34 giorni tra i 1000 e i 2000 metri.
Per chi ama la neve e il ghiaccio, e ne ha fatto un tema di ricerca scientifica e di vita, non è bello assistere a questa ritirata, ma è doveroso, come per un medico, seguire l’evoluzione dei sintomi del proprio paziente. La cura spetta alla politica, all’economia, alla società, che non vogliono tuttavia farla. Le emissioni di gas serra proseguono imperterrite, si pensa più a costruire armi che pannelli solari e la neve è destinata sempre più a svanire dai nostri panorami.
"LA MIA VITA IN ALTO"
Così, per riuscire a godermela ancora un po’, nel 2018 ho deciso di trasferirmi a 1650 metri di quota in alta valle di Susa. È una regione alpina interna di per sé non molto nevosa, ma l’inverno, anche se si è addolcito e ristretto in durata, vi mantiene ancora i suoi tratti tradizionali. Un po’ di freddo c’è e il paesaggio da dicembre ad aprile è di colore tendente al bianco, sebbene siano diventati frequenti i periodi con i prati ingialliti percorsi dalle sinuose strisce delle piste da sci innevate artificialmente. Di tanto in tanto si verificano però le condizioni per nevicate intense, che tuttavia si sono fatte più “appenniniche”: arrivano rapidamente e altrettanto rapidamente scompaiono, mangiate dal soffio di una sciroccata. Così, sapendo che nella vita mi sarà concesso di vederne ancora forse una decina, allorché le previsioni annunciano una situazione prodiga di fiocchi mi organizzo per non perderla.
È capitato l’ultima volta a inizio marzo 2024. Dopo l’inverno più caldo di sempre sul Nord Italia, con inconsueta pioggia fino a 2000 metri il 1° e l’11 dicembre, e il 3 gennaio, ecco che sabato 2 marzo una massiccia perturbazione atlantica copre i cieli piemontesi.

Inizia a nevicare fitto fitto, la stufa ruggisce, le riserve di cibo in baita non mancano, scorte di libri pure, che ne venga quanta ne vuole.
Tra domenica e lunedì nella nostra borgata Vazon, a monte di Oulx, ne cadono ben 90 centimetri, un manto soffice e vaporoso che ci avvolge nel silenzio. Bisogna essere consapevoli di questo regalo del cielo e gustarlo in tutta la sua bellezza, scattando decine di fotografie.
Ma l’idillio dura poco e bisogna tornare alla realtà: più in basso la neve bagnata ha fatto strage di alberi, la strada di accesso alla frazione è bloccata e la linea elettrica ha subìto danni. Siamo isolati e con la corrente a singhiozzo. Si scavano piccoli sentieri, larghi come i piedi, per i percorsi che da sempre collegano i luoghi degli abitati d’alta quota: l’accesso alla legnaia, al letamaio, alle case dei vicini. Dal silenzio ovattato dell’alba si passa al raschiare della pala sul selciato, al rombo della fresa con cui tentiamo di liberare l’automobile. Ma alla fine desistiamo e passiamo del buon tempo domestico vicino al fuoco.
Dopo due giorni di magnifico isolamento, l’inesorabile richiamo delle attività urbane decreta una discesa a ciaspole. Abbandoniamo l’automobile sepolta e affrontiamo alcune ore di faticoso cammino nella neve alta facendo slalom tra gli alberi caduti e quelli che stanno per cadere.
Tutto è molto bello, ma le ore passano, l’incanto lascia il posto all’inquietudine.
All’imbrunire siamo di nuovo in mezzo al brulicare dei turisti e delle auto che spruzzano fanghiglia a bordo strada. Anche nel 2024, a due passi da autostrade e centri commerciali, grazie a una nevicata un po’ fuori scala, è ancora possibile vivere avventure genuine. Ripasseremo a recuperare la vettura dopo una decina di giorni, quando le squadre dei forestali avranno terminato di rimuovere centinaia di tronchi finiti di traverso sulla strada.
La neve è un oggetto di ricerca scientifica, una risorsa idrica quando si trasforma in acqua, un rischio naturale quando si trasforma in valanga, una ricchezza turistica quando copre le piste da sci, un tema letterario quando si trasforma in poesia. La neve è stata un elemento importante del clima italiano, ora sempre meno presente.

Gli scenari futuri segnati dal riscaldamento globale la confineranno sempre più in alto e per meno tempo, privandoci di un elemento naturale profondamente ancorato alla nostra cultura. Nevicherà ancora, ma sempre più dovremo andare a cercare i bei fiocchi come quando si va in pellegrinaggio, verso santuari montani dove avverrà la bianca apparizione. I ghiacci e le nevi di un tempo, divorati da un mondo sempre più caldo, rimarranno solo in fotografia.
Luca Mercalli è Presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus, si occupa di ricerca sulla storia del clima e dei ghiacciai delle Alpi. È editorialista de Il Fatto Quotidiano. Ha collaborato con la Rai, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana e con il Climate Broadcast Network dell’Unione Europea. Di recente ha pubblicato Breve storia del clima in Italia (Einaudi, 2025).
Montagna – La vita in alto è il nuovo numero di Mappe
Il sesto numero di MAPPE, intitolato Montagna - La vita in alto, è in vendita a 19,50 euro.
- in tutte le librerie;
- sul nostro store online (sconto del 5% per tutti e del 20% per gli iscritti Touring);
- nei Punti Touring (scontodel 20% per gli iscritti Touring).
MAPPE è il nuovo progetto del Touring Club Italiano: un libro con la scansione di una rivista e una rivista con l’eleganza di un libro. Un tema diverso ogni numero, un numero ogni tre mesi, diversi generi e linguaggi che si alternano.